Perchè amiamo il disagio mercificato: da Zerocalcare all’Indie Pop italiano
Tanto si è parlato di “Strappare lungo i bordi“, la miniserie netflixiana di Michele Rech, aka Zerocalcare, che ha conquistato l’Italia. Tanti gli aneddoti dell’Armadillo e di Zero salvati tra le note dei nostri telefoni, così come tanti sono gli apprezzamenti. Poi le critiche al gergo romano – come se un prodotto visivo in dialetto improvvisamente intimorisca i fruitori. Ma come sono correlati tra loro l’indie e Zerocalcare?
Oggi analizziamo la narrazione di Zerocalcare e quella dei neo-cantautori indie, che si rivelano correlate da una stessa ostentazione del disagio, a volte benefica, a volte meno. Entrambe le narrazioni sono figlie di una generazione che ripudia le storie pratiche composte da un inizio e una fine, come quelle raccontate dai cantautori delle generazioni passate. Piuttosto, predilige analisi introspettive che confermano e giustificano il dolore, anziché offrirgli soluzioni e modelli da seguire.
L’indie e Zerocalcare
Zerocalcare adopera la stessa narrazione mainstream del disagio dei neo artisti. “Strappare lungo i bordi” conferma nient’altro che ciò che vogliamo sentirci raccontare, ma soprattutto, ciò che vogliamo raccontare a noi stessi. Non cerchiamo più le storie dal lieto fine, così come non perdiamo più tempo con l’esatto opposto, ovvero quei racconti cui protagonista è la tragedia. Stiamo nel mezzo, e vogliamo parole che ci facciano sentire compresi nel nostro disagio quotidiano. Ecco come “Strappare lungo i bordi” ha riscosso successo, soprattutto perché nella narrazione del disagio comune, aveva già la strada spianata dai nostri amati cantanti generalmente identificati come indie pop. Loro che narrano il disagio di tutti, tranne dei veri “disagiati”, quelli che il disagio lo vivono non per scelta, ma come condizione precaria tangibile di vita.
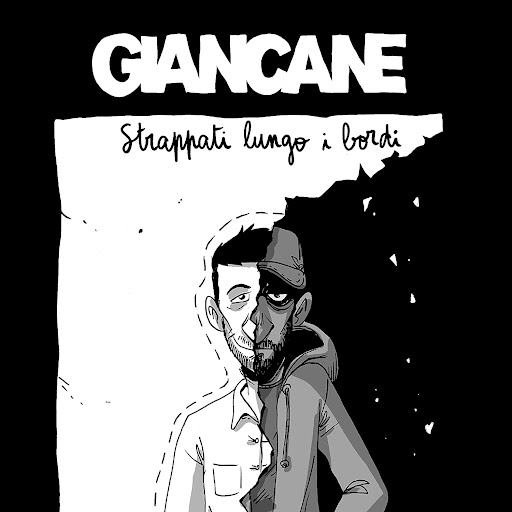
Il disagio semplice o pseudo-disagio
Se penso a chi parla di disagi reali e purtroppo tangibili, mi vengono in mente subito i rapper. In effetti, il rap viene ormai identificato come il genere musicale che denuncia. L’indie pop in voga negli ultimi anni – per cui mi sento in dovere di escludere i precursori, quelli dell’alt rock italiano, quali Marlene Kuntz, Baustelle, Afterhours, eccetera – si identifica come quel genere musicale che parla di un “disagio semplice”, o pseudo-disagio, di ansia sociale, di paturnie e di sorrisi… che in realtà sono paresi. Essere “disagiati” nel 2021 fa figo: meno se si vive il vero disagio, sì se si tratta di un disagio, per così dire, semplice, puramente estetico.
Il suicidio trattato da Zerocalcare
Zerocalcare, però, nella serie, oltre a narrare questo disagio quotidiano, narra anche qualcosa di cui difficilmente parlano, ad esempio, gli artisti indie pop: il suicidio. È vero, lo fa solo alla fine, ma gli dà la giusta importanza, quella che merita: non troppa, né poca. Quello che mi preoccupa, però, è vedere cosa la gente ha appreso dalla miniserie in questione: l’ostentazione del disagio “semplice”, l’umiltà di un percorso di vita comune ai molti, l’individualismo ed egocentrismo (camuffati da umiltà) di cui quasi tutti siamo affetti, i sensi di colpa anche quando il mondo va avanti senza le nostre azioni. Insomma, tutto, davvero tutto, tranne che la narrazione del suicidio.
Il suicidio, apoteosi del disagio mentale, è un argomento difficilmente trattabile, specialmente nella musica che deve portare a casa milioni di ascolti. Lo è, sia perché risulta impossibile da mercificare, sia perché siamo nell’epoca della rimozione della tragedia. Speravo, infatti, che qualcuno tra i narratori mainstream del disagio parlasse di suicidio, perché questa narrazione che si limita allo pseudo-disagio, fa sembrare tutti più sensibili, quando, in realtà, continuiamo a non esserlo di fronte i veri drammi degli altri. Come, ad esempio, il suicidio, appunto, che è un problema vero.
“I suicidi” di gIANMARIA
Nonostante ciò, di suicidio ne ha parlato, recentemente, il giovane artista gIANMARIA, noto soprattutto per essere concorrente dell’attuale edizione di XFactor, nel suo brano “I suicidi”. Parole struggenti quanto veritiere, che dimostrano come la tematica non sia per nulla estranea alla nuova generazione. gIANMARIA, infatti, ha 18 anni e sa già perché gli adulti si uccidono. Il giovane artista, portavoce della neo-sensibilità di questi tempi, non ostenta né mercifica il disagio, anzi lo descrive, osservandolo dall’alto, rispettandolo.
Se escludessimo il suicidio, quasi come se Michele Rech non ne avesse mai parlato nella serie, “Strappare lungo i bordi” si limiterebbe a essere l’ennesima narrazione mainstream che abbraccia tutti coloro che, più per moda, si sentono “disagiati”. In effetti, questo spiegherebbe l’aver scelto Giancane per la colonna sonora della serie. Proprio lui che prima di “Strappare lungo i bordi”, ha fatto un disco dal nome “Ansia e Disagio”.
Lo storytelling del disagio
Lo Stato Sociale, Gazzelle, Franco 126, Ugo Borghetti, Calcutta, Coez, Carl Brave, Frah Quintale, Giancane, eccetera, non si discostano per nulla dallo storytelling di Zerocalcare. Nella sua accezione più negativa, infatti, il suo storytelling risulta essere mainstream e permeato dei luoghi comuni tipici dello pseudo-disagio. Se da un lato questi artisti parlano di gente comune – non dal punto di vista della ribellione politica o romantica, come nella musica di Rino Gaetano o Vasco Rossi, ma più per quanto concerne i loro pensieri – da un altro, mercificano il disagio.
L’indie-pop italiano (di adesso) abbraccia chi mangia le unghie, chi beve gin tonic, chi si annoia alle feste, chi ostenta timidezza, chi è riservato ma in realtà non rinuncia mai alla vita sociale, e così via. Non abbraccia i veri timidi, quelli bloccati nelle loro stanze; non abbraccia i disagiati, quelli in strada senza soldi né casa; e non abbraccia nemmeno i veri malati mentali. Quelli che di disagio non ne parlerebbero mai in maniera mercificata.
Zerocalcare versione Netflix abbraccia quelli che stanno nel mezzo, proprio come fa l’indie-pop, che non parla mai dei veri emarginati. Avvicinandosi alla narrazione del suicidio, però, sebbene lo faccia solo nel finale, ha provato a discostarsi dagli artisti di cui sopra.
Giorgio Gaber cantava “Far finta di essere sani“, un brano del ’73 che ora non troverebbe spazio né comprensione. Dove il disagio più semplice va di moda, oggi, non ci sarebbe alcun bisogno di fingere di essere sani, piuttosto, sarebbe comodo fingere di essere malati.
“Per ora rimando il suicidio
E faccio un gruppo di studio
Le masse, la lotta di classe, i testi gramsciani
Far finta di essere sani”
Cristiana Dicembre
Ho iniziato a scrivere per pensare ai fatti miei, ora scrivo solo di quelli degli altri. Di solito mi faccio descrivere dalla musica che più mi piace, per esempio: il mio album preferito ha una banana sullo sfondo.



Scusami ma mi viene una domanda: ma perché l’indie dovrebbe parlare del suicidio?
Ci sono artisti del passato che ne hanno parlato e che ne parlano in alcune canzoni, ok, perché l’indie e la sarebbe intellettualmente disonesto a non parlarne?
Non è un genere musicale che nasce per professare nulla, sono ragazzi di 25 o 30 anni portavoci di loro stessi, che vivono la stessa realtà che viviamo noi.
C’è sempre qualocos’altro di cui si potrebbe parlare, ma se non se ne parla non significa che lo si snobbi.
Questo ovviamente vale per l’indie ma per tutta la cultura che definisci “mainstream”.
Ma quindi per te, quando non è disagio reale, nel senso di tangibile – come quello narrato dai rappers – è per forza “pseudo-disagio”?? Secondo me invece, il più volte da te citato Calcutta, per esempio, esprime stati d’animo altrettanto reali e autentici, al di là delle definizioni da te affibbiate a caso. La mercificazione semmai è avvenuta successivamente, da parte di chi ha replicato all’infinito determinate tematiche. Comunque, cosa è autentico e cosa è falso lo decide, o meglio lo percepisce, ogni singolo ascoltatore, non una recensione su un sito.
Non mi convince l’assunto a mio avviso semplicistico di questo pezzo. Il giudizio estetico viene ridotto ad una valutazione moralistica dei contenuti e in base a quella si prende a misura assoluta il solito, riduttivo concetto di mainstream. Non si può valutare in modo completo e intelligente l’efficacia di un’opera basandosi sul solo contenuto né entrando nel merito di una presunta “altezza morale” di questo. Parlare in arte del disagio della quotidianità non solo è legittimo e può essere esteticamente più che valido, ma è stato un pilastro di molti capolavori artistici a partire dal ‘900. Se invece si vuole proporre un’analisi sociologica del fenomeno legato alle espressioni artistiche o pseudo tali citate, questo è un altro discorso. Ma allora bisognerebbe separare nettamente le due cose.