Caro Motta ti scrivo: grazie per averci restituito il diritto alla semplicità
“Semplice” è una parola che deriva dal latino simplex, composto dalla radice sem- (uno solo) e da quella di plectere (piegare): piegato una sola volta. Un’etimologia curiosa che richiama un’immagine chiara: non quella di un complesso origami, ma un foglio che si apre con un gesto unico. Il nuovo album di Motta è esattamente questo: un viaggio tra le pieghe dell’anima presentato nell’essenzialità di una lettera che chiede solo di essere prima aperta e poi letta, o meglio ascoltata.
E come qualsiasi lettera che possa definirsi tale, anche quella di Motta prevede un destinatario identificabile già dal titolo del primo brano dell’album: “A te”. Una seconda persona singolare che in realtà raccoglie una pluralità di interlocutori, artista compreso, e che profuma di sbagli e di abbracci.
A dare il via al racconto di Motta è un misto di solennità e potenza.
Per lui, la ben nota frase “in principio era il verbo” prende la forma di “in principio era il suono”. L’incipit di “Semplice” è una partenza dolcemente ammaliante, un crescendo delicato ma pervasivo che si fa sempre più ritmico e penetrante. Un’apertura che risente molto dell’esperienza di Motta nella composizione di colonne sonore per il cinema e che, proprio come in un film, accompagna e a tratti quasi scrive la storia.
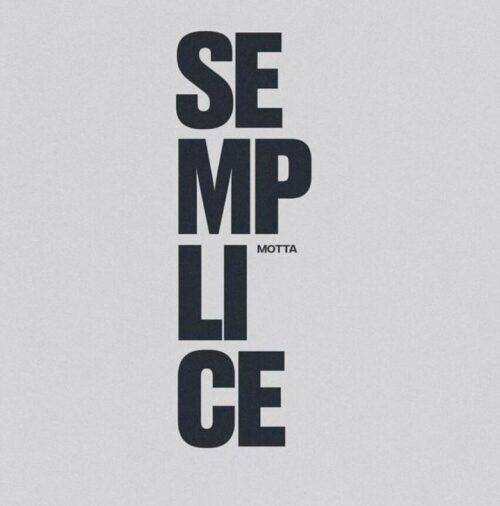
Una storia che inizia ad emergere meglio nel secondo brano. Qui all’iniziale centralità del suono si sostituisce la preponderanza della voce narrante che accenna una storia, quasi “inevitabile”, d’amore:
“Ma poi finisco per amarti”, canta Motta.
Più ci si addentra nel disco, più diventa chiaro come quell’unica linea curva che definisce il “semplice” è in realtà il risultato di tante pieghe distese a fatica. Un percorso che inizia a venire fuori con “Via della luce”, la terza traccia dell’album. Un brano intimo, che si apre al suono di un piano e con la voce di Motta che spiega, ai suoi interlocutori ma anche un po’ a se stesso:
“Da questa parte di città sembra di stare in un paese, o forse io sono cambiato e ho imparato a godermi le cose”.
La parola chiave di questo testo è consapevolezza: quella che si riesce a raggiungere solo dopo essersi persi, rinnegati, e infine desiderati.
Un punto di svolta importante, tanto che permea anche il brano immediatamente successivo. Qui Motta veste i panni del cantastorie e con l’aiuto della sorella Alice, che si rivela essere la voce complementare del fratello, apre uno squarcio sul quotidiano. E non un quotidiano qualunque, ma quello che in tanti ci siamo ritrovati a dover vivere in questo lungo e difficile periodo e che in qualche modo ci ha reso più lenti. In questo testo, però, la lentezza non assume una connotazione negativa, non sfocia nello stallo assoluto, ma rivela tutto il suo potenziale, tutto il suo bagaglio di opportunità. La lentezza detta un tempo nuovo e immersivo, in cui semplice diventa sinonimo di normale e ci dà finalmente il diritto di urlare senza vergogna:
“Non ho più paura di stare a sognare qualcosa di normale”.

E anzi, proprio le paure, anche quelle, diventano qualcosa di semplice.
“Semplice come la paura di conoscere me stesso”, recita Motta nel brano che dà il titolo all’album, “Semplice come la piccola parte di me che preferisco”.
In maniera apparentemente contraddittoria al crescere dell’introspezione del disco corrisponde una diminuzione della complessità. L’interiorità non diventa qualcosa di complicato e indecifrabile, ma un nocciolo piccolo e (im)perfetto da custodire nel palmo di una mano. Un’essenza che non è priva di contraddizioni, ma che si riconosce unica proprio grazie ad esse:
“Sono l’estate d’autunno”, canta più avanti Motta, e “Se io fossi stato un altro chi lo sa”.
Un’accettazione di sé che arriva verso la fine come una dolce consolazione, un approdo a lungo sognato e infine raggiunto.
Ma quale migliore conclusione se non una ripartenza? L’ultimo brano dell’album ci proietta in una galassia diversa che in tanti probabilmente hanno conosciuto: quella dove gravita l’asteroide B-612 del Piccolo Principe.
“Parlami dell’universo, di tutto quello che mi sono perso mentre ero perso in un altro universo”.
La frase in apertura è un collegamento diretto e immediato per chiunque abbia avuto la fortuna di leggere il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry e di viaggiare nello spazio insieme al protagonista. Il richiamo arriva diretto anche con il ritornello:
“Quando tu guardi una rosa tu pensi a qualcuno, io penso a qualcosa”.
Come non ripensare alla celebre frase: “È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”?
Quest’ultimo brano, scritto insieme a Brunori Sas, si dilata per più di 6 minuti in un lungo finale strumentale che, esattamente come i titoli di coda di un film, mette il punto alla lettera di Motta e ci lascia in tasca una verità da tenere sempre a mente: i viaggi più difficili servono solo a raggiungere le cose più semplici.
Foto di Chiara Mirelli per Rolling Stone
Altro su Motta qui
Annachiara Piscitelli
Linguista creativa, danzatrice maldestra, viaggiatrice incallita alla costante ricerca della Bellezza. Sono devota all'antica arte del comunicare, etimologicamente "rendere comune", perché la voce di ognuno di noi risuona in un'eco più grande.


